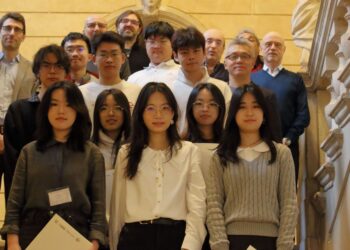Essere in grado di gestire le emergenze umanitarie e chirurgiche nei paesi in via di sviluppo è un compito difficile per un medico. L’università di Verona insieme a Medici senza frontiere ha creato il master in Chirurgia tropicale e delle emergenze umanitarie per la formazione di chirurghi in grado di operare in contesti disagiati. Elda Baggio, direttrice del master e docente di Chirurgia vascolare dell’ateneo, ci ha parlato della sua esperienza sul campo e del significato formativo del master.
Professoressa Baggio, quale valore aggiunto può offrire questo master ai laureati in Medicina e chirurgia?
Il master in Chirurgia tropicale e delle emergenze umanitarie nasce dalla consapevolezza che fare il chirurgo quando le risorse sono limitate, come nei paesi in via di sviluppo o durante emergenze umanitarie (terremoti, maremoti, disastri soprattutto) richiede conoscenze e competenze diverse rispetto all’esercizio della professione chirurgica in un sistema sanitario sviluppato che ha a disposizione professionalità diverse. Questo master è il primo tentativo di dare una professionalità specifica al volontariato chirurgico, una professionalità che necessita di conoscenze e competenze in ambiti diversi quali l’ostetricia, l’ortopedia e la chirurgia plastica. Bisogna essere preparati a gestire le malattie infettive che sono presenti nei paesi in via di sviluppo come malaria, Hiv e tubercolosi. Per partecipare è obbligatoria la certificazione ALS (Advanced Life Support) per la rianimazione dell’adulto e la certificazione PALS (Pediatric Advanced Life Support) per la rianimazione del bambino. L’inserimento di entrambe queste certificazioni nel programma è stato possibile grazie alla disponibilità della dottoressa Paola Perfetti e del dottor Paolo Biban. È doveroso ringraziare a questo proposito, i molti medici coinvolti e il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera universitaria, il dottor Sandro Caffi, che ha concesso l’uso del polo didattico di via Madonna del Terraglio a Verona. Il corso prevede anche una parte per la gestione del cosiddetto burn-out, cioè di analisi delle problematiche psicologiche che può avere il chirurgo chiamato a lavorare in situazioni difficili o in situazioni di conflitto armato. Non va poi dimenticato che in situazioni di emergenza si devono possedere anche conoscenze per così dire “logistiche” su come si allestisce una sala operatoria, come si potabilizza l’acqua e come si organizza il recupero del sangue.
Si tratta del primo master a livello europeo in questo ambito. Perché secondo lei è stata scelta proprio la città di Verona?
Per quanto si riferisce alla sede di Verona, non è stata una vera scelta. In realtà tutto nasce da un incontro casuale, di molti anni fa, tra me e il responsabile Msf di Verona, l’infaticabile dottor Giovanni Di Cera. All’inizio del 2010 egli fece, per così dire da tramite con il dottor Gianfranco Di Maio, responsabile medico per Msf Italia. Ci incontrammo e rapidamente mettemmo a punto il programma. Il Master ha un comitato scientifico di docenti dell’Università che si sono subito resi disponibili. Per quanto riguarda invece i moduli del programma, i responsabili sono non solo i docenti dell’ateneo, ma anche i responsabili di Msf Italia e di Msf Belgio, oltre a docenti esterni. In tutti i casi però si tratta sempre di persone con lunga esperienza sul campo, ed è questo, accanto al programma, il valore aggiunto del master.
Il master prevede un periodo di tirocinio in Burundi. Qual è il valore formativo di un’esperienza del genere?
Il periodo obbligatorio di frequenza in un ospedale di un paese in via di sviluppo, è secondo noi il completamento doveroso di un master di questo tipo. L’esperienza pratica è indispensabile in tutti i campi, ma in particolar modo quando si parla di realtà sanitarie inserite in un ambiente sociale e culturale profondamente diverso da quello in cui abitualmente viviamo e lavoriamo. Anche dal punto di vista del rapporto con la malattia e la morte le problematiche sono diverse. Per questo motivo, è previsto un corso che tratta il concetto di salute in un’ottica antropologica e l’organizzazione dei sistemi sanitari nei paesi a risorse limitate. La scelta del Burundi nasce dal progetto di collaborazione didattica ed assistenziale tra la facoltà di medicina dell’Università di Verona e l’ Università di Ngozi una cittadina del nord del paese.
La prima volta che è stata in Burundi ci ha detto che, nonostante la sua consolidata esperienza di chirurga, ha dovuto in un certo senso ripartire da zero. Ci può raccontare la sua esperienza?
Personalmente ho cominciato ad andare in Burundi nel novembre del 2002 agli esordi del progetto di collaborazione con l’università di Ngozi. All’inizio il progetto prevedeva solo una partecipazione didattica alla Scuola per tecnici della salute dell’università. I tecnici della salute sono una figura particolare: essi frequentano un corso universitario della durata di 4 anni che ne fa degli infermieri cui poi vengono affidati compiti di responsabilità, in particolare nella gestione dei distretti sanitari dove nella maggior parte dei casi manca il medico. In quegli anni il paese era alla fine di un periodo di guerra etnica fra Tutsi e Hutu, migliaia erano le persone massacrate, l’ospedale era assolutamente inagibile e gli unici medici, un pediatra, un’anestesista ed un chirurgo di origine russa, erano pagati dagli organismi internazionali. A partire dal 2005, dopo una riqualificazione edilizia fatta con fondi della Banca Mondiale è iniziata anche la nostra collaborazione assistenziale con l’ospedale, al fine di rendere possibile la formazione pratica degli studenti del corso di laurea in Infermieristica. Personalmente prima di iniziare a lavorare in ospedale durante le missioni in Burundi, nel febbraio 2005 sono stata per un mese all’Ospedale di Mutoyi distante 70 km da quello di Ngozi e gestito dal Vispe di Milano, per imparare come gestire le patologie di più frequente riscontro. In particolare è importante il taglio cesareo che nella maggior parte degli ospedali africani, rappresenta una delle urgenze più frequenti. Inoltre è indispensabile ridiventare medico a “tutto tondo”, per così dire, nel senso che l’esperienza più frequente è quella di dover gestire il malato nel senso globale dei suoi bisogni sanitari. Uno scopre quindi in prima persona che non sa fare molto di quello che gli sarebbe necessario sapere, per contro sa fare molto che non gli serve assolutamente. Questo comporta un rimettersi in discussione globale, una revisione di quelli che noi consideriamo bisogni sanitari e non solo primari. E’ comunque un’esperienza non solo medica quella del “rimettersi in discussione”, fa pensare alle proprie priorità e a ciò che rende il proprio lavoro gratificante oltreché utile.