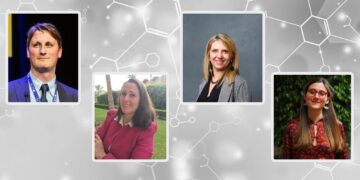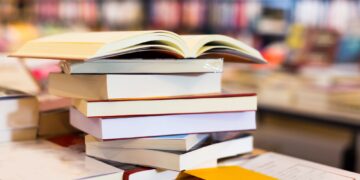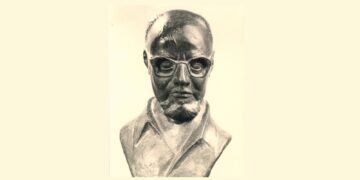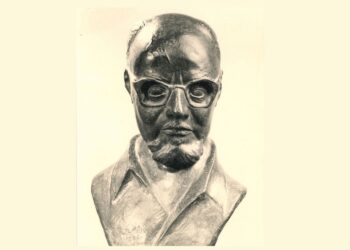“Una delle cause dell’attuale crisi è lo scarso valore che nel nostro Paese viene dato al fattore scientifico”, con queste parole Angelo Guerraggio, docente di Ottimizzazione e di Storia della Matematica dell’Università “Bocconi” si è presentato nel corso del quarto appuntamento del ciclo di conferenze “Essere italiani oggi – Per una identità politica culturale religiosa”. L’incontro, dal titolo “Scienza e Industria” ha ospitato anche Alessandro Crespi, ingegnere e presidente UCID. A coordinare Roberto Giacobazzi, preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'ateneo di Verona
Il valore della scienza. Per Guerraggio “sembra che questo Paese abbia una specializzazione produttiva che non sembra richiedere Scienza. Invece la scienza è il modo in cui lo stato aumenta la propria ricchezza”. Tuttavia, secondo il relatore, la situazione si può ancora cambiare, non siamo condannati a restare “periferia dell’impero”. Per mostrare la via di questo cambiamento il relatore ha ripercorso i 150 anni della storia d’Italia. Innanzi tutto il periodo post Unità quando al governo del Paese sedeva la Destra Storica: “Nella classe dirigente di allora c’era una larga presenza di uomini di scienza, i quali misero a disposizione le loro conoscenze nel tentativo di modernizzare l’Italia”. Nell’età Giolittiana però, “quello che sembrava un matrimonio indissolubile tra scienza e politica denota i primi scricchiolii. Infatti arrivarono i cosiddetti politici di professione e gli uomini di scienza vennero allontanati. Il fascismo, invece, mostrò grande attenzione nei confronti della scienza, attenzione però “vissuta e praticata in maniera miope, perché il rapporto politica-scienza non funziona come una comunicazione dall’alto al basso: ci vuole libertà perché si sviluppi la Scienza”. Infine a cavallo tra anni Cinquanta e Sessanta si ebbe un “nuovo periodo di innamoramento tra scienza e politica”: sono gli anni del boom economico. Poi i primi scandali politici che portarono all’arresto di Ippolito e Marotta e le morti di Adriano Olivetti, Mario Chu e di Mattei furono “una Caporetto per la scienza che, nei suoi rapporti con la società e con l’industria, non ebbe nessuna Vittorio Veneto né riscossa del Piave”.
La scienza per le persone. “La questione della scienza e dell’industria è una questione di persone”. Questo il messaggio che Alessandro Crespi ha voluto lanciare con il suo intervento. “Cinquant’anni fa il sistema organizzativo dell’impresa era una piramide gerarchica molto stretta – ha spiegato il relatore – poi diventò una organizzazione sempre più ampia in cui la persona umana ha contato sempre di più”. Con l’introduzione e il perfezionamento della catena di montaggio, si instaurò all’interno delle aziende una specie di terrorismo, nella forma di “una scienza dell’organizzazione umana in cui ogni spazio omogeneo di attività viene valutato al massimo in termini di qualità e tempo”. Il terrorismo portò alla specializzazione del lavoro, con incredibili progressi in campo scientifico, “ma in questo sviluppo si è perso l’uomo”. Con la nascita della figura del manager, invece, la persona umana è sempre più influente nello sviluppo dell’impresa. “Oggi i giovani hanno perso il senso del lavoro e stanno per perdere il senso dello studio” ammonisce Crespi. “La logica di oggi è: studio per lavorare, lavoro per guadagnare, guadagno per spendere e in tutto questo si perde il senso della vita”.