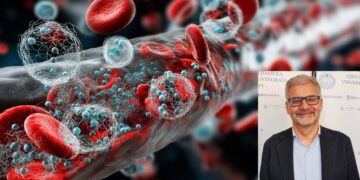Gelsibachicoltura nel Veronese: attraverso il passato verso il futuro. Riattivazione di processi locali virtuosi legati alla seta per il benessere dei territori e delle persone. È il titolo di uno dei tre progetti Univr vincitore del bando “Ricerca e sviluppo 2024” promosso dalla Fondazione Cariverona.
Fanno parte del team di progettazione e ricerca Anna Paini e Attilio Stella del dipartimento Culture e civiltà e Veronica Polin del dipartimento di Scienze economiche. Il progetto biennale prevede quattro annualità di assegni di ricerca. Al momento è stato attivato l’assegno di ricerca biennale di antropologia, di cui è risultata vincitrice Giuliana Arnone.
Il lavoro si inserisce in una nuova stagione di fioritura delle fibre tessili naturali e sostenibili, focalizzandosi sull’intreccio fra processi culturali economici storici e ambientali legati al loro recupero e valorizzazione contemporanea.
Ne parliamo con Anna Paini, docente di Antropologia culturale e coordinatrice del progetto.
Professoressa Paini, ci presenta il taglio del progetto?
Il progetto adotta un approccio interdisciplinare che fa dialogare antropologia, economia e storia puntando sulla gelsibachicoltura in quanto patrimonio culturale investito di significati contemporanei. Questi da un lato attingono a dimensioni esperienziali del passato, dall’altro innescano dinamiche e processi di creatività sociale e culturale in grado di promuovere lo sviluppo locale e migliorare la qualità dell’ambiente. In questa fase di transizione ecologica, le realtà aziendali e territoriali che puntano sulla produzione e impiego locale di fibre tessili naturali possono dare un contributo concreto nell’individuare modelli virtuosi di sviluppo locale partecipativo e orientati al benessere del territorio e delle persone.
Il progetto biennale propone il rilancio della filiera della seta in ambito veronese attraverso una messa in rete di diverse realtà pubblico-private del territorio. Il primo obiettivo è la creazione di un ‘gelseto diffuso’ a cui stanno partecipando diverse aziende agricole della provincia. Questo permetterà successivamente la sperimentazione dell’allevamento della bachicoltura presso le realtà coinvolte e lo sviluppo di un prototipo di filato da parte dell’azienda Manifattura Italiana Cucirini (MIC), partner fondamentale del progetto. Stiamo toccando con mano l’interesse, il coinvolgimento e la passione delle situazioni coinvolte, ma siamo consapevoli che occorre recuperare saperi e un saper fare legato all’esperienza che, a partire dalla seconda metà del ‘900, è venuta man mano affievolendosi.
Quali realtà vede coinvolte?
Oltre ai due dipartimenti di Culture e Civiltà e di Scienze Economiche Univr ad alcune realtà agricole del veronese – impegnate nella messa a dimora di piante di gelso per partecipare al ’gelseto diffuso’ – all’Istituto agrario Stefani-Bentegodi (sede di Villafranca) e a una rete di associazioni del territorio, come già segnalato è partner del progetto l’Azienda Manifattura Italiana Cucirini (MIC) con sede a Vallese. I bandi ‘Ricerca e Sviluppo’ della Fondazione Cariverona, infatti, richiedono una forte partnership fra Università e aziende del territorio.
Quali sono le potenzialità del progetto?
La letteratura evidenzia quanto la gelsicoltura produca benefici economici non monetari: controllo dell’erosione, assorbimento del CO2 atmosferico, mitigazione dei cambiamenti climatici. Progetti come questo, hanno il pregio di far comprendere il ruolo e gli effetti che la gelsibachicoltura può svolgere in termini di sostenibilità ambientale.
Inoltre, il recupero di memorie, pratiche e saperi vissuti in chiave contemporanea è anche in parte legate alla crescente consapevolezza delle rilevanti ricadute negative che alcuni ambiti del settore della moda hanno sull’ambiente, che sta spingendo un numero crescente di imprese italiane a orientarsi verso modelli di economica circolare con produzione e utilizzo di materie prime sostenibili. Il progetto punta su modelli di consumo consapevoli. Il progetto articola il concetto di sostenibilità nelle sue varie dimensioni, coerentemente con quanto previsto dall’Agenda 2030.
La gelsibachicoltura ha giocato un ruolo rilevante nella storia di Verona?
La gelsicoltura e la bachicoltura nel passato fornivano un contributo economico di un certo rilievo al bilancio delle famiglie contadine, consentendo loro di avere liquidità in tempi rapidi, nel presente si propongono come una risorsa per favorire la biodiversità, in territori sempre più votati alla monocultura, e al contempo riattivano memorie e pratiche del passato percepite come patrimonio culturale fortemente identitario. Per quanto riguarda la gelsicoltura, la lunga tradizione è testimoniata dai gelsi ancora presenti sul territorio veronese, dai manufatti, emerge dalle memorie orali che stiamo raccogliendo e dalle fonti archivistiche.
E oggi?
Queste esperienze di rilancio della seta permettono inoltre di avviare nuove sperimentazioni sia a livello artigianale sia industriale. A livello regionale si assiste a una ripresa della filiera della bachicoltura che va di pari passo all’innovatività nell’utilizzo della fibra; segnalo che oltre agli impieghi più tradizionali come quello nell’abbigliamento, il filato di seta oggi trova una serie di applicazioni in ambito biomedicale e la proteina della sericina viene utilizzata nella cosmesi. Faccio inoltre presente che la Regione del Veneto ha approvato una legge a sostegno della gelsibachicoltura proprio la scorsa primavera.
Infine, ci tenevo a anticipare che il ‘Cantiere’ della Gelsibachicoltura nel veronese sarà presentato nell’ambito dell’edizione biennale di Verona Tessile (14-18 maggio 2025) in collaborazione con l’Associazione Ad Maiora, l’associazione fotografica VeronaOFF, il partner aziendale MIC, il Museo dell’arte del Ricamo Don Mazza e il Museo di Storia Naturale, che ci ospiterà. Sarà anche l’occasione per un confronto con altre realtà regionali, fra le quali il CREA di Padova, partner del nostro progetto.
SM