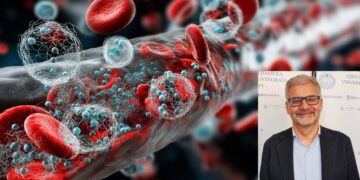“Applicazione di formulati innovativi per la modulazione dell’epoca di maturazione delle uve in risposta ai cambiamenti climatici” è uno dei tre progetti dell’università di Verona che ha vinto un finanziamento nell’ambito del bando “Ricerca e sviluppo 2024”, promosso dalla Fondazione Cariverona. Il progetto è nato nel dipartimento di Biotecnologie dell’ateneo scaligero ed è coordinato da Marianna Fasoli, docente di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree.
Il lavoro si concentra sull’applicazione di formulati biostimolanti durante il processo di maturazione delle uve, con l’obiettivo di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Ne parliamo Marianna Fasoli, coordinatrice del progetto.
Professoressa Fasoli, ci può presentare il focus del progetto?
Tra gli effetti più evidenti del cambiamento climatico sui vigneti, vi è l’anticipo della maturazione del frutto, che porta spesso a un disaccoppiamento tra l’accumulo di zuccheri e la sintesi di metaboliti secondari di qualità. Ciò comporta gradi alcolici più alti, una bassa acidità delle uve e la modifica dei profili aromatici e polifenolici. È noto che l’applicazione fogliare di ormoni di sintesi può rallentare l’accumulo di zuccheri senza alterare la maturazione finale delle uve, regolando o ritardando una maturazione troppo accelerata e sbilanciata. In un’ottica di sostenibilità, il progetto si propone di sviluppare prototipi di formulati a base di estratti vegetali e microalghe, testandone l’efficacia nel controllo attivo della maturazione delle uve delle varietà Corvina e Corvinone, fondamentali per la viticoltura della Valpolicella. La sperimentazione include anche la valutazione dell’effetto delle applicazioni fogliari sull’appassimento post-raccolta delle uve e sulla microvinificazione. L’impatto dei trattamenti sulle dinamiche di sviluppo e maturazione delle uve verrà studiato a livello multidisciplinare, attraverso analisi morfologiche, tecnologiche e molecolari, in particolare trascrittomica e metabolomica.
Quali sono e che ruolo hanno avuto le realtà coinvolte?
Il partenariato con la Fabbrica Cooperativa Perfosfati di Cerea ha offerto l’opportunità di formulare e caratterizzare prototipi di biostimolanti capaci di mimare i fitormoni vegetali, consentendo un posticipo dell’epoca di raccolta e preservando l’equilibrio e la qualità delle uve, mitigando gli effetti di condizioni climatiche avverse. Fondamentale è stata anche la collaborazione con la Società Agricola Fratelli Tedeschi Srl, che ha permesso di focalizzare la sperimentazione su varietà autoctone della Valpolicella, rispondendo alle esigenze territoriali da cui è nata la ricerca.
Qual è stata la spinta che ha portato all’idea del progetto?
Nei prossimi 30 anni, l’effetto serra modificherà le condizioni di produzione, le caratteristiche organolettiche e i mercati di destinazione dei vini. Con il clima che cambia, si osserva un anticipo progressivo del ciclo riproduttivo della vite e dell’epoca di raccolta, causando modifiche sia nelle caratteristiche dei vini che nella resa in vigneto. Le strategie finora a disposizione del settore vitivinicolo hanno mostrato effetti insoddisfacenti o sono economicamente poco sostenibili (ad esempio, defogliazioni), oppure, come nel caso degli ormoni di sintesi, presentano limitazioni legislative che non sono in linea con una gestione sostenibile del vigneto.
Come si inserisce il progetto nel settore vitivinicolo di Verona e quali prospettive si presentano?
Nel veronese, gli ettari destinati alla viticoltura superano i 30.200, per cui l’individuazione di nuove formulazioni e protocolli applicativi che aumentino la resistenza delle coltivazioni alle variazioni climatiche è di primaria importanza per questo territorio. L’adozione di tecniche colturali efficaci e sostenibili potrà contribuire sia alla sostenibilità degli interventi agronomici tradizionali che alla preservazione delle varietà del patrimonio ampelografico locale e nazionale.
SM